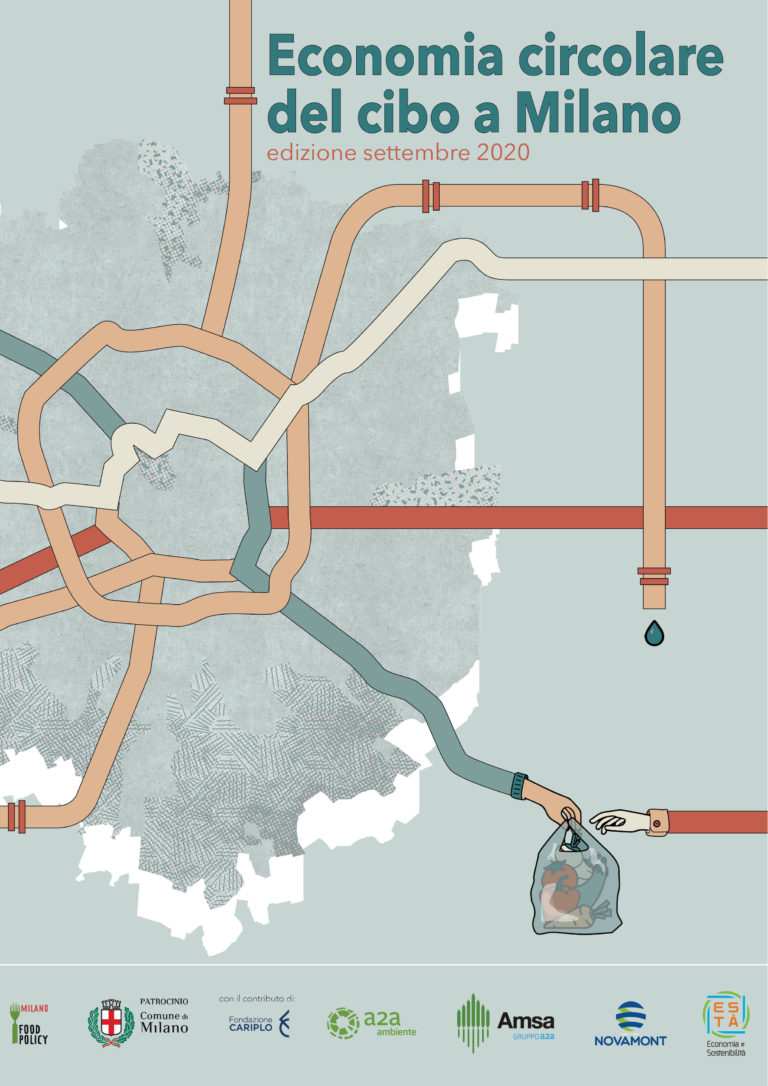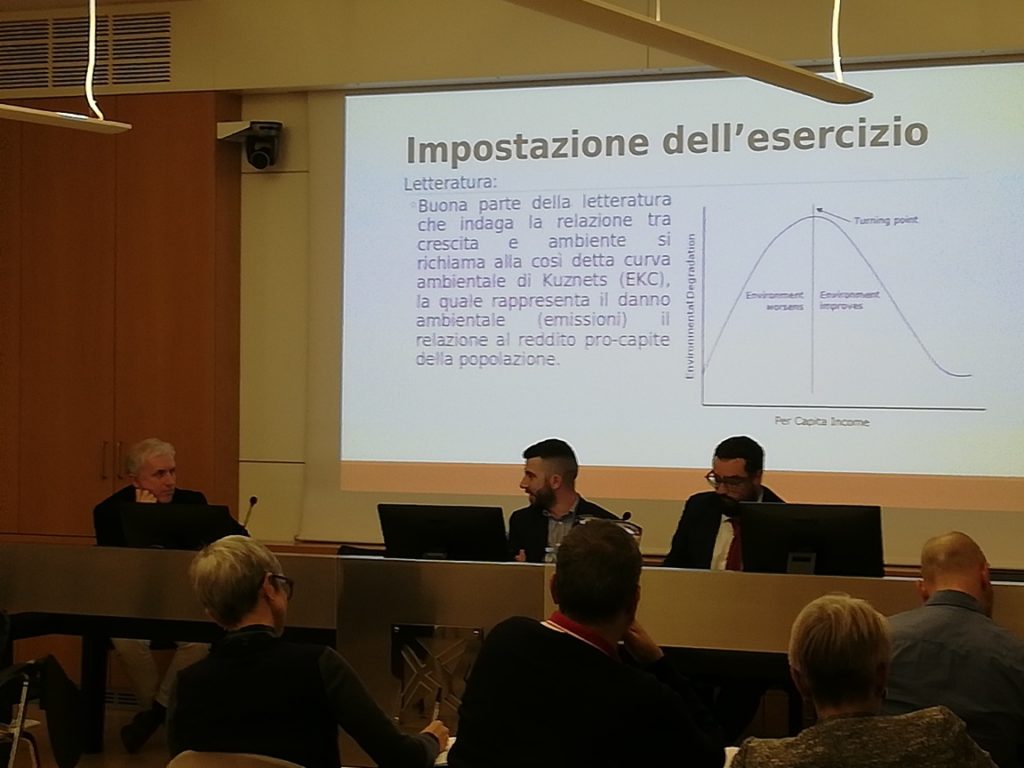Economia circolare del cibo a Milano
15 Ottobre 2020
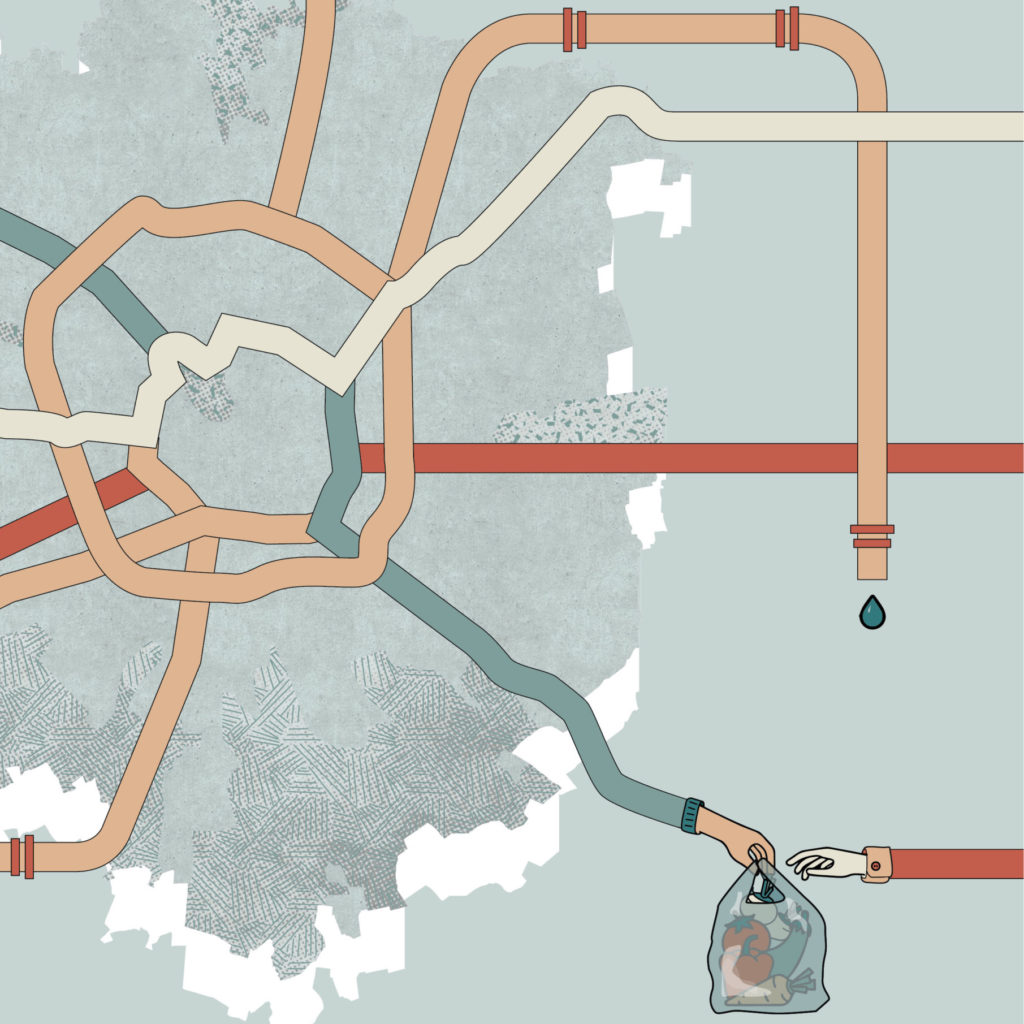
È possibile fare di Milano un laboratorio permanente di politiche integrate rivolte all’economia circolare del cibo? La ricerca Economia circolare del cibo a Milano, condotta dal centro di ricerca Economia e Sostenibilità (ESTà), fornisce gli elementi di base per connettere e valorizzare in ottica circolare le risorse esistenti nel territorio milanese: competenze, driver istituzionali, asset industriali e opportunità. L’obiettivo è sostenere il Comune di Milano e Fondazione Cariplo nel loro ruolo di impulso, supporto e facilitazione di tutte le forme di innovazione sociale, tecnologica e organizzativa che possono concorrere ad attuare gli obiettivi della Food Policy e i principi dell’economia circolare.
Il sistema alimentare (produzione, trasformazione, logistica, distribuzione, consumo, gestione delle eccedenze e dei rifiuti) è pervasivo e rilevante dal punto di vista degli impatti ambientali, sociali ed economici. L’applicazione a tale sistema dei principi dell’economia circolare, minimizza l’estrazione dall’ambiente di risorse finite, riduce i tassi e i tempi di trasformazione della materia in rifiuti, promuove modalità di riciclaggio e upcycling di questi ultimi. Le città in questo senso sono contesti privilegiati, poiché concentrano in uno spazio limitato una grande quantità di rifiuti, vedono la presenza di organizzazioni, tecnologie e saperi che lavorano per garantire diminuzione, recupero o trasformazione di questi rifiuti, combinando avanzamento tecnologico con forme di innovazione sociale che danno origine a nuove economie e nuovi servizi; infine possono promuovere, direttamente o con azioni di advocacy, politiche integrate che governano il sistema del cibo nel suo complesso.
La ricerca analizza tre ambiti che hanno grande impatto sul sistema alimentare: i rifiuti urbani legati al sistema alimentare (in particolare frazione organica dei rifiuti solidi urbani, imballaggi in plastica e in carta-cartone), le eccedenze di cibo fresco destinabili all’alimentazione umana, i fanghi di depurazione delle acque reflue. Per ciascun argomento, fornisce un inquadramento generale (funzionale sia all’individuazione delle questioni principali, sia a soddisfare una finalità divulgativa) e un’analisi specifica sulla città di Milano, analizzando gli attori del sistema connessi con l’interesse pubblico e i principali meccanismi di interazione reciproca; valutando le dimensioni dei flussi fisici, il valore economico del sistema (principalmente per i rifiuti) e i suoi impatti ambientali; segnalando le innovazioni di prodotto e di processo più significative per dimensioni e per potenzialità di miglioramento in futuro. La ricerca è stata condotta intervistando 40 esperti appartenenti sia a soggetti chiave del territorio milanese (A2A Ambiente, AMSA, AMAT, SogeMi, Milano Ristorazione, Politecnico di Milano, CAP, MM, Ufficio Food Policy del Comune di Milano, Recup, Banco Alimentare), sia a soggetti che operano anche a scala sovralocale (Biorepack, COREPLA, COMIECO, CIC, Assocarta, Assobioplastiche, Novamont), sia a soggetti che si occupano a vario titolo di economia circolare (Materia Rinnovabile, UNISG).
Nella sezione relativa ai rifiuti urbani, l’inquadramento generale del tema presenta l’importanza di una corretta raccolta differenziata (e le strategie per favorirla), in particolare al fine di migliorare i processi di riciclo del rifiuto umido (che portano alla produzione di compost, biogas e biometano) e di produrre nuovi prodotti a valore aggiunto.
A livello di dati si segnala come: la presenza nel rifiuto umido di materiale non compostabile (MNC) generi costi pari a 52 milioni di euro (costi diretti per la separazione del MNC e costi indiretti per lo smaltimento); le modalità di raccolta porta a porta facciano registrare una percentuale di MNC pari al 4,3%, mentre quelle a cassonetto stradale una percentuale pari al 10,1%; il principale contaminante dell’umido resti il sacchetto di plastica tradizionale (nel quale è vietato conferire l’umido) che costituisce quasi il 27% del totale del MNC. Questi dati sono ancora più rilevanti se si pensa al ruolo della raccolta differenziata dell’umido (principale frazione raccolta) nel raggiungimento dei nuovi obiettivi di riciclo fissati a livello europeo (55% al 2025, 60% al 2030 e 65% al 2035).
La sezione prosegue analizzando: i processi di trattamento della frazione organica (digestione anaerobica e compostaggio) e alcune problematiche legate agli impianti (si segnala in particolare una carenza impiantistica pari a 1 milione di tonnellate, che diventeranno 2 milioni nel 2025, per colmare la quale sarebbe necessario un investimento di 2 miliardi di euro); le relative innovazioni di processo per superare le problematiche di cui sopra (investimenti nelle tecnologie di preselezione, processi di compostaggio ad hoc per gli scarti); le recenti innovazioni di prodotto che consentono di estrarre dal rifiuto umido prodotti a valore aggiunto maggiore rispetto a compost, biogas e biometano (mangimi, prodotti per alimentazione umana, biopesticidi, bioplastiche e biomateriali vari). Nella sezione vengono evidenziati: il grande valore ambientale del compost di qualità (attenuazione dei fenomeni di desertificazione, miglioramento delle caratteristiche fisiche dei terreni, apporto dei principali elementi fertilizzanti) a cui non corrisponde un altrettanto significativo valore di mercato (5-10 euro/tonnellata); la tendenza a spostare i processi di trattamento dell’umido verso la digestione anaerobica (spinta dagli incentivi al biometano) con conseguente diminuzione della produzione di compost.
La ricerca analizza anche i processi di raccolta e trattamento dei rifiuti da imballaggi e food service in plastica e carta, individuando i casi in cui è auspicabile la sostituzione dei prodotti tradizionali (i poliaccoppiati, gli imballaggi altamente inquinati da cibo) con analoghi prodotti in materiali compostabili che possano quindi essere conferiti insieme all’umido.
In questa sezione l’analisi sulla città di Milano vede la ricostruzione dei flussi e della geografia della gestione dei rifiuti urbani, affidata ad AMSA/A2A: Milano è la più grande città europea con il sistema di raccolta porta a porta e la quantità di rifiuto umido pro capite raccolta è tra le più alte registrate nelle capitali europee: nel 2019 il tasso di raccolta differenziata era al 61,8%. L’analisi relativa a Milano prosegue: presentando le esperienze recenti più significative realizzate all’interno del perimetro urbano (il miglioramento della raccolta dell’umido nei mercati settimanali scoperti – 2500 tonnellate come target, con un risparmio di 420 tonnellate di CO2 – i progetti di mediazione linguistico culturale per migliorare la raccolta differenziata degli esercizi etnici di ristorazione con somministrazione); stimando fatturato, occupati ed emissioni evitate per singola frazione raccolta, dimostrando che un sistema circolare di gestione dei rifiuti implica fatturati maggiori, un più elevato impatto occupazionale e una diminuzione di emissioni di CO2: per esempio, considerando che la frazione organica del Comune di Milano ha raggiunto nel 2019 le 154.000 tonnellate, si possono stimare 230 unità lavorative, un fatturato di oltre 41 milioni di euro (includendo anche le numerose attività correlate al riciclo, ad esempio il supporto tecnico per la realizzazione e la progettazione di impianti, le attività per la valorizzazione e l’impiego del compost) e 32.000 tonnellate annue di emissioni di CO2 evitate. La sezione si conclude segnalando i punti più deboli del sistema milanese (carenza impiantistica per la frazione umida, destinazione del plasmix ad incenerimento).
Nella sezione relativa alla redistribuzione delle eccedenze di cibo fresco in ottica solidaristica, l’inquadramento generale del tema presenta il problema dello spreco alimentare, le motivazioni per le quali è diventato una priorità a livello mondiale, i volumi aggregati e gli impatti (ambientali, sociali, economici, culturali), i problemi definitori e di assenza di standard di misurazione condivisi (che rendono difficile un’azione di contrasto efficace) e alcune soluzioni innovative nella prevenzione e gestione delle eccedenze. L’analisi su Milano si concentra sull’esperienza del primo hub di quartiere (microdistretto veloce di redistribuzione delle eccedenze) che nel 2019 ha recuperato e distribuito 77 tonnellate di cibo edibile a 3.950 persone (di cui 1.480 minori), con un risparmio di 170-240 tonnellate di emissioni di CO2. Tale esperienza ha consentito di ovviare alla crisi del sistema di aiuti alimentari generatasi durante l’emergenza COVID (la maggior parte dei volontari che si occupano di redistribuzione delle eccedenze è costituita da soggetti a rischio perché anziani), permettendo al Comune, in collaborazione con altri soggetti, di organizzare “Milano Aiuta”, un sistema di 10 hub temporanei dislocati nelle zone periferiche della città per la consegna di generi alimentari ai soggetti fragili durante il lockdown. Vengono poi analizzate le esperienze di recupero nei mercati settimanali scoperti (54 tonnellate recuperate da Recup, 21 tonnellate di emissioni di CO2 evitate) e delle due società possedute dal Comune di Milano che si occupano di ristorazione collettiva (Milano Ristorazione, 59 tonnellate di pane e 79 tonnellate di frutta recuperati, per un totale di 83 tonnellate di emissioni di CO2 evitate) e dell’ortomercato (SogeMI, 1.500 tonnellate di ortofrutta recuperate, 590 tonnellate di emissioni di CO2 evitate).
Nella sezione relativa ai fanghi di depurazione delle acque reflue, l’inquadramento generale del tema presenta: i processi di produzione e trattamento dei fanghi negli impianti di depurazione (i fanghi costituiscono il 90% degli scarti prodotti dal processo di depurazione delle acque); gli impieghi attuali di tali fanghi (ovvero riutilizzo in agricoltura per spandimento, produzione di compost e di ammendanti – l’utilizzo agricolo e la possibilità di estrarre dai fanghi elementi che tornano all’agricoltura, costituiscono i motivi per i quali la ricerca ha preso in considerazione il tema – produzione di biogas, incenerimento e smaltimento in discarica -. NB: a livello nazionale poco meno del 20% dei fanghi viene smaltito in discarica, per il restante 80% la destinazione agricola è l’opzione prevalente); i principali problemi derivanti dall’utilizzo dei fanghi in agricoltura (questioni normative, presenza di inquinanti – metalli pesanti, microinquinanti organici, farmaci e sostanze psicotrope, agenti patogeni – e quindi possibile contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, maleodorazioni).
L’aumento del volume dei fanghi, i costi di trattamento e smaltimento (che possono incidere fino al 60% del totale di costi della depurazione, sebbene il volume dei fanghi prodotti da un depuratore rappresenti solo una minima parte delle acque in ingresso) e le limitazioni allo smaltimento in discarica, inducono a focalizzarsi sulle possibilità di riutilizzo e recupero dei fanghi (i depuratori come presidi di circolarità): massimizzazione della produzione di biogas, recupero di materia (riutilizzo in agricoltura – diretto per spandimento o indiretto con produzione di compost – per i fanghi di alta qualità, recupero di specifici prodotti – per esempio nutrienti come il fosforo – elemento fondamentale per l’agricoltura e in via di esaurimento – e l’azoto o chemicals organici come biopolimeri o cellulosa).
In questa sezione l’analisi territoriale si è concentrata sia su Milano che sulla Città Metropolitana. In particolare vengono esaminati: i processi produttivi, le quantità e i destini dei fanghi generati da Metropolitana Milanese (i due depuratori di Milano, 59.000 tonnellate di fanghi tal quale prodotti nel 2019 e destinati all’agricoltura o a vettore energetico, nessun ricorso allo smaltimento in discarica) e CAP Holding (i 40 depuratori della Città Metropolitana, 59.000 tonnellate di fanghi prodotti nel 2018 destinati all’agricoltura – anche con produzione di fertilizzanti – e a vettore energetico, con ricorso marginale allo smaltimento in discarica); le innovazioni in termini di recupero di materia ed energia e le tendenze future: per MM la ricerca di soluzioni tecnologiche che consentano di inserire un processo di digestione anaerobica nella linea fanghi di entrambi i depuratori senza erigere cupole, la sperimentazione della produzione di fertilizzanti in linea nel depuratore di Nosedo e la sperimentazione di modalità diverse di combustione anche per il recupero di fosforo dalle ceneri; per CAP la completa uscita dallo smaltimento in discarica e dallo spandimento in agricoltura, tramite conferimento del 25% dei fanghi (quelli «alta qualità») in agricoltura come fertilizzanti, riduzione del volume dei fanghi attraverso la produzione di biogas (e biometano) e incenerimento per un recupero di fosforo dalle ceneri.