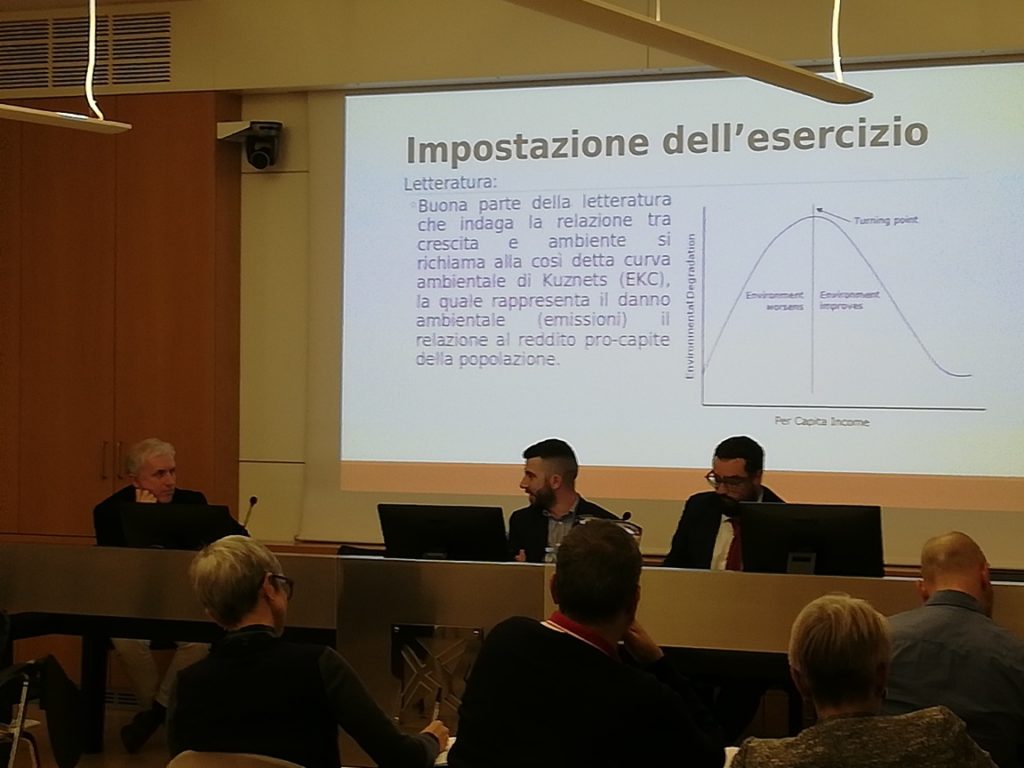Voto, società, politiche e quadro finanziario
15 Novembre 2022

di Roberto Romano
L’esito delle elezioni (settembre 2022) ha sollevato riflessioni politiche ed economiche, se non culturali, che sottendono una serie di domande che meglio di altre potrebbero aiutare la comprensione dei fenomeni sociali alla base dei risultati.
La domanda fondamentale che la narrazione più o meno condivisa rimuove è la seguente: dopo trent’anni di politiche economiche restrittive, in cui il lavoro è scivolato non solo ai margini dell’analisi economica, ma anche al margine dell’attività politica, unitamente a una prospettiva economico-sociale che rimuove il lavoro come soggetto del cambiamento, era possibile un esito elettorale diverso?
Sebbene la Storia ci ricordi che la partecipazione è parte integrante dello sviluppo economico e sociale, non appena si interrompe questo processo la partecipazione diventa un lusso che 1) polarizza la società e 2) la piega su dispute che riflettono lo stato d’animo (cultura) dei più o meno agiati, mentre il malessere (40% della popolazione) non si riconosce più nei partiti o leader che li guidano.
Il voto di settembre, forse, non è mai stato così limpido. Da un lato abbiamo quasi il 40% di astensione, che per alcune categorie lambisce il 50% degli aventi diritto (disoccupati) e il 45% tra gli operai e affini; da un altro lato la potenziale coalizione di governo può contare solo sul 27% degli aventi diritto al voto. Un governo indiscutibilmente di minoranza, ma con una rappresentanza sociale che potrebbe condizionarlo. In effetti, il centrodestra intercetta il 55% del voto operaio che si è espresso, contro il 15% della coalizione di centrosinistra. I 5 Stelle intercettano quasi il 17% del voto operaio, che ben si bilancia con il 24% di disoccupati e inoccupati, diversamente dal centrosinistra (PD, Verdi-Sinistra-Più Europa) che raccoglie il 21%. A proposito di disoccupati e inoccupati, il centrodestra intercetta quasi il 43% dei voti, con un risultato (sorprendente?) di Fratelli d’Italia che sfiora il 21%. In altri termini, i 5 Stelle sono il soggetto politico più rappresentativo di questa particolare categoria. Il Reddito di Cittadinanza è stato evidentemente percepito come uno strumento utile da quelle persone di cui pochi vogliono farsi carico.
Solo i pensionati sembrano fedeli alla Storia del Paese, sebbene in misura più contenuta. Infatti, Fratelli d’Italia supera il PD con quasi il 28% dei votanti, seguito dal PD (27%) e 5 Stelle (10%).
Al netto degli studenti che hanno votato a maggioranza 5 Stelle (25%), seguiti da PD (24%), Più Europa (11%), Fratelli d’Italia (10%) e Verdi-Sinistra (9%), perché la così detta sinistra non ha intercettato il voto storico di appartenenza? Dipende dalle politiche che ha seguito quando era al governo? Dalla perdita del legame storico con le classi popolari e dalla capacità e desiderio di rappresentare il disagio sociale nella sfera politica?
Queste domande non possono essere affrontate guardando a quanto accaduto nel recente passato. La Storia è lenta, ma prima o poi presenta il conto di 30 anni di politiche economiche e sociali. Occorre partire dal 1990 per catturare come la società e il ben-essere siano cambiati nel tempo. Senza questa narrazione sarebbe tecnicamente impossibile leggere quanto accaduto. La Storia conta e senza la conoscenza di questa Storia non è possibile rimediare alcunché.
Da un lato abbiamo un PIL reale nazionale che ormai è distante da quello tedesco e francese e, tra le altre cose, non ha nemmeno recuperato le posizioni del 2007. Gli investimenti, che restituiscono la percezione del futuro, sono in rapporto al PIL sempre più bassi dell’area euro e dei paesi considerati. In qualche modo, il livello degli investimenti è l’altra faccia della specializzazione produttiva. Al Paese non servono più investimenti data la bassa specializzazione del sistema economico in generale. Anche i consumi reali seguono l’andamento del PIL e fanno il paio con la crescita dell’avanzo commerciale, sostanzialmente legato alla dinamica del costo del lavoro e alla caduta dei consumi che hanno contratto le importazioni, unitamente a un indice GINI in costante crescita, sebbene in misura meno accentuata a partire dal 2002.
Per comprendere come il lavoro sia stato vittima di alcune politiche, possiamo indagare l’output per occupato a partire dal 1990. La storia è poco nota, ma la cosiddetta produttività nazionale era più alta di Francia e Germania tra il 1990 e il 2002. Dopo diventa una frazione di quella dei Paesi menzionati. Ma non è tutto. I salari versus la produttività tra il 1990 e il 2021 restituiscono qualcosa di impopolare, una sorta di spirale che passa da un lieve miglioramento fino al 2007, per poi ritornare alle stesse posizioni del 1992 per ciò che riguarda i salari. In altri termini, le politiche del lavoro hanno eroso il salario e ridotto la produttività, lasciando inermi e sconsolati proprio il riferimento sociale storico della sinistra.
Si poteva fare diversamente. Sebbene le politiche europee abbiano condizionato le politiche, queste potevano anche avere un segno diverso, se solo si fosse ascoltato il proprio corpo elettorale.
Ora la destra sembrerebbe rappresentare il lavoro, i disoccupati e una parte non banale dei pensionati. Hanno davanti a sé una legge di bilancio scritta da altri. Difficile modificare il segno date le disponibilità finanziarie, almeno che non si riscriva la matrice dell’economia italiana. Nel frattempo, la sinistra farebbe bene a raccontare tutta la storia e non cadere in un’idea di politica come esercizio riservato alle persone più agiate.